Dalla presenza al Cnr a un intervento video per festeggiare i trent’anni di internet in Italia; che Matteo Renzi oggi sia davvero a Pisa o no fa poca differenza. Le politiche di genere e la lotta alle discriminazioni e all’omo-transfobia si trovano in una situazione di immobilismo. Anzi, per la precisione: il governo Renzi può vantare più hashtag che azioni positive.
Decreto Legge sul femminicidio, forse
Cominciamo dagli antefatti: nel 2013 il governo Letta approva il cosiddetto decreto legge sul femminicidio. Degli 11 articoli del decreto, solo 5 sono dedicati alla violenza di genere, il resto riguarda furti di rame, protezione civile, NoTav, frodi informatiche e province. Sembrerebbe che con questo decreto le donne vengano sfruttate per poter far passare leggi repressive. Il decreto stabilisce anche le condizioni di irrevocabilità della denuncia. Le stime dicono che circa 7 milioni di donne hanno subito violenza fisica o sessuale, e solo il 7% di queste ha denunciato l’aggressore. Si tratta di una percentuale che la dice lunga sul livello di sicurezza che lo Stato è in grado di garantire alla donna abusata, e sul percorso di protezione che le è dovuto in caso scelga di denunciare – scelta problematica e niente affatto scontata.
Inoltre, anche quando la donna denuncia, spesso non viene creduta proprio nei luoghi previsti dalla legge, e cioè prima dalle Forze dell’Ordine e poi in tribunale, dove se viene creduta spesso si minimizzano le violenze ricevute. Evidentemente, un problema profondamente strutturale come la violenza di genere non può essere risolto con un decreto legge che non prende in considerazione la cultura sessista in cui viviamo.
Certo, questo non è imputabile al governo Renzi, ma dal decreto sul femminicidio derivano sia i miseri stanziamenti di fondi di cui vi parleremo dopo, sia il Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, entrato in vigore l’anno scorso.
Un piano d’azione straordinariamente… Vuoto
Breve analisi linguistica del Piano d’azione: si citano la convenzione di Istanbul, le Nazioni Unite e le raccomandazioni internazionali; si usano parole come “multifattorialità”, “fenomeno strutturale”, “approccio olistico” e “contrasto allo stereotipo di genere”; si parla di una “strategia basata su una governance multilivello” e di “azioni in sinergia”. E poi che succede davvero?
- Lʼelaborazione dei dati sulla violenza contro le donne passa dall’Istat – che aveva fatto un buon lavoro – al Dipartimento per le pari opportunità. Ce n’era bisogno?
- Viene costituita una “Banca dati nazionale dedicata al fenomeno”, con gruppo di esperti che dovrà elaborare proposte di progettazione e di sviluppo del sistema informativo. Eh?
- Per quanto riguarda il settore media e comunicazione, il Piano intende sensibilizzare gli operatori e non formarli in modo specifico, e fa riferimento all’adozione di un generico piano di autoregolamentazione. Anche in questo ambito la prevenzione della violenza è affidata a un gruppo di esperti – un altro! – che dovrà occuparsi anche di cambiare il linguaggio nella pubblica amministrazione. Come?
- Educazione alla parità e al rispetto delle differenze: il Governo elaborerà un documento di indirizzo, darà l’opportunità di fare formazione ai docenti – non è obbligatoria, è facoltativa – e darà pure la possibilità di rivedere i libri di testo, «fermo restando la libertà di scelta e di rispetto dei destinatari dei libri di testo, nonché della libertà di edizione». Quindi ok, non c’è davvero nulla che sia obbligatorio cambiare.
Il Piano d’Azione prosegue, ma restando sulla scuola: a quali differenze vuole educare il governo Renzi? A tutte, o solo a quelle minime indispensabili? Ce lo chiediamo pensando ai libretti realizzati da UNAR e Istituto Beck due anni fa, intitolati “Educare alla diversità a scuola”, indirizzati ai docenti e fatti ritirare dalla ministra Giannini dopo gli schiamazzi di Bagnasco e dei giornali Tempi e Avvenire.
Un altro momento di cui il governo Renzi dovrebbe vergognarsi.
#CiaoneCodiceRosa
Con la legge di stabilità 2016 si è passati dal Codice Rosa ospedaliero, che prevedeva la formazione degli operatori sanitari al riconoscimento delle situazioni di violenza per fornire supporto alla donna maltrattata, al Percorso di tutela delle vittime di violenza.
I punti critici sono due. Primo: si assimila la violenza contro le donne a qualunque altra forma di violenza contro i soggetti vulnerabili, e quindi anche minori, anziani, persone con disabilità. La legge nega sia le radici della violenza contro le donne, che sono culturali e storiche, sia la convenzione di Istanbul, approvata all’unanimità nel 2013, che prevede un percorso individuale per le donne vittime di violenza maschile.
Secondo: è istituito l’obbligo di denuncia una volta accertato il fatto di violenza nella struttura sanitaria. Solo in questo caso saranno attivati i gruppi multidisciplinari di assistenza giudiziaria, sanitaria e sociale e tutto il percorso di assistenza, in collaborazione con i centri antiviolenza. L’obbligo di denuncia è l’ennesima soluzione paternalistica al problema, nel quale si ritiene la donna incapace di decidere del suo destino. Per di più, si ignorano anche i bisogni della singola vittima, che potrebbe preferire attuare soluzioni diverse o continuare la propria vita così com’era, per una pluralità di motivi, non ultimo l’incolumità di minori.
Inoltre, come ci insegnano i numerosi casi di femminicidio, spesso le denunce non sono bastate ad evitare la morte di chi le ha sporte, e questo perché o rimanevano inascoltate, o perché, in caso di detenzione, il carcere si dimostrava punitivo e non rieducativo. La denuncia, obbligatoria o no, non risolve il problema del sessismo, dell’educazione di stampo patriarcale, di tutte quelle che sono le vere radici della violenza di genere.
Fondi per i centri antiviolenza: #MatteoRispondi
Fin dagli anni Novanta, a occuparsi del percorso di uscita dalla violenza sono stati i centri dedicati e le case rifugio. Il governo Renzi non garantisce fondi adeguati a tutte queste strutture: l’Huffington Post ha fatto notare che dei fondi stanziati per il biennio 2013/2014 grazie al decreto legge sul femminicidio, solo due milioni sono andati alle strutture esistenti che accolgono e assistono le donne vittime di violenza. Visto che i centri individuati dal governo sono 352, la cifra che spetta a ognuno è appena 3mila euro all’anno.
Non solo: in base alla ricerca condotta da ActionAid in collaborazione con Dataninja, «nessuna Regione italiana può dirsi totalmente trasparente nella gestione dei fondi stanziati con la legge 119/2013 per prevenire e contrastare la violenza sulle donne». Questo significa che le delibere di alcune regioni e province sono irrintracciabili, sia online che su richiesta diretta; che in quasi la totalità dei casi non è possibile avere informazioni precise sulla destinazione delle risorse per tipo di intervento e per area strutturale, e a volte nemmeno informazioni sulle strutture antiviolenza presenti sul territorio. In generale, le Regioni non hanno incluso nelle delibere i nomi delle strutture antiviolenza territoriali che beneficiano dei fondi, unica eccezione la Sardegna.
Che ne è, poi, della raccomandazione del Consiglio d’Europa secondo cui dovremmo avere un posto letto nelle case rifugio ogni 7500 abitanti e un centro dʼemergenza ogni 50mila abitanti? Matteo, rispondi: in Italia dovrebbero esserci circa 5700 posti letto, e invece ce ne sono più o meno 500.
Aborto in Italia: missione quasi impossibile
Non ci sono novità positive nemmeno per quanto riguarda la legge sull’aborto, la 194. Il 15 gennaio scorso l’aborto effettuato oltre i 90 giorni di gravidanza è stato depenalizzato, ma allo stesso tempo la multa per il reato di aborto clandestino è passata da 51 euro a una cifra che oscilla fra i 5mila e i 10mila euro. Ancora un volta il Governo ha attuato una tattica punitiva nei confronti delle donne dimenticando il problema principale: l’obiezione di coscienza, che nel complesso è del 70% circa ma è pure in aumento, e in alcune regioni supera il 90. Le stime ci dicono che, nel 2012, 21mila donne su 100mila si sono rivolte a strutture di altre province. Di queste il 40% è stata costretta a cambiare addirittura regione.
#MoltoPiùDiCirinnà
Attenzione a dire, Matteo, che le leggi sono state portate a casa. Al 29 aprile 2016 l’Italia non ha né una legge per il contrasto dell’omotransfobia né una riconoscimento legale per le unioni civili fra persone dello stesso sesso. Il decreto Scalfarotto è in corso di esame in commissione da due anni. Due anni esatti, li compie oggi: buon compleanno!
Per non parlare dell’approvazione della legge sulle unioni civili, con quella brutta discussione in aula dove, tanto per dirne una, le stepchild adoption – una parola così intellegibile – sono diventate strizza cialde ad ozio o stoccald addosso. Il punto, però, non è esattamente linguistico, o non soltanto tale. Il ddl Cirinnà, più che sancire la parità dei diritti, ribadisce la disuguaglianza fra persone eterosessuali e omosessuali, nei fatti e nei termini. Da una parte famiglie, dall’altra specifica formazione sociale; da una parte il matrimonio, da quell’altra le unioni civili; e soprattutto, da una parte la possibilità, per le coppie etero, di adottare il figlio del partner (dal 1983), e dall’altra…nulla. Non c’è da stupirsi se nella classifica 2015 stilata da ILGA-Europe in base ai diritti LGBTQ l’Italia si trovi al 32esimo posto su 49 stati.
In ogni caso, quello che ci fa più male sapere, come collettivo femminista queer e come singol*, è che con ogni probabilità la legge sulle unioni civili disciplinerà le nostre vite per molti anni a venire. Lo abbiamo già detto il 23 gennaio e lo ribadiamo: noi pretendiamo #moltopiùdiCirinnà!
Anche stavolta non è #LaVoltaBuona
Vogliamo concludere ricordando che, da molti mesi, il Dipartimento per le Pari Opportunità non ha un Ministro o una Ministra dedicati, contrariamente a tutti gli altri governi della seconda Repubblica, e da novembre è addirittura privo di direzione. A maggior ragione ora – ma lo sarebbe anche solo per principio – riteniamo sia necessaria la presenza di una Ministero che coordini le varie attività e faccia rispettare gli ordinamenti statali e i patti presi a livello internazionale. Matteo, non basta assegnare dei ministeri a delle donne per risolvere i problemi di genere in Italia!
Matteo, che altro dire: noi #NonSiamoSerene.





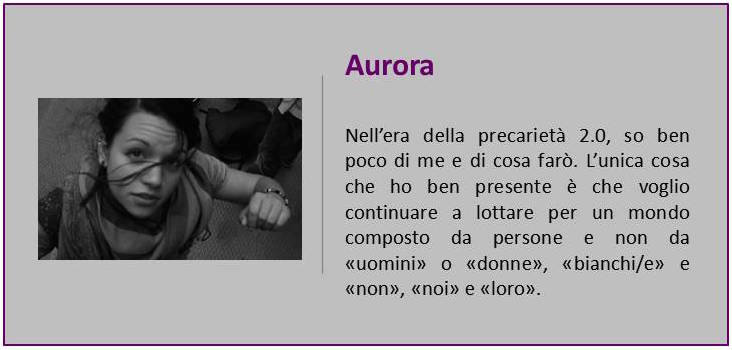




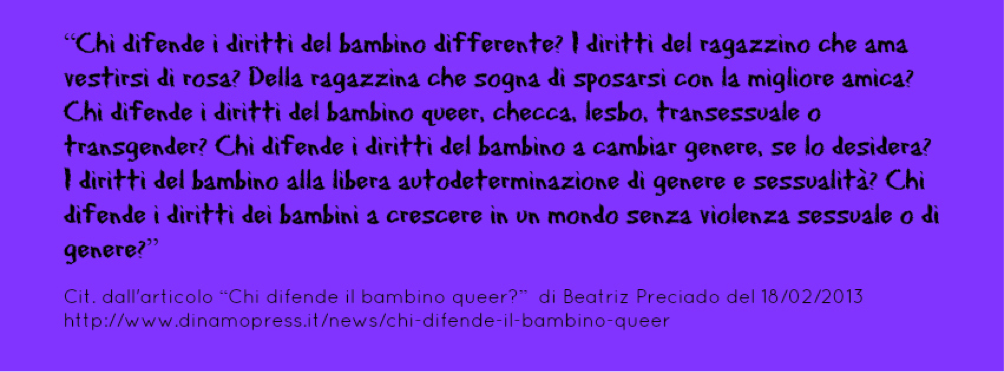
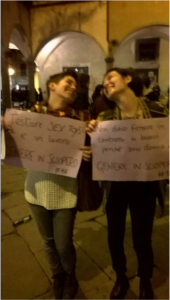


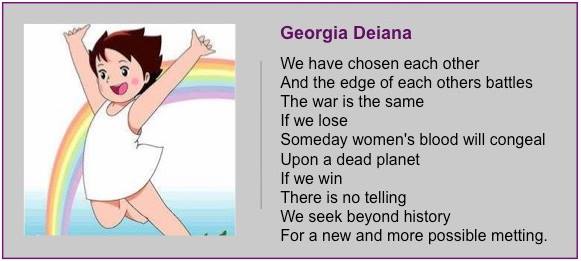
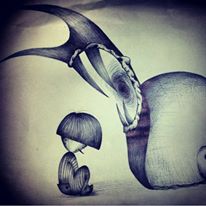














 Meravigliose serate a suon di musica, video postporno e considerazioni a partire dal nostro vissuto e dalla nostra quotidianità ci hanno accompagnat* ed aiutat* nell’autoformazione; finché alcun* di noi hanno avvertito la necessità di concretizzare queste riunioni in qualcosa che avesse un maggior impatto politico.
Meravigliose serate a suon di musica, video postporno e considerazioni a partire dal nostro vissuto e dalla nostra quotidianità ci hanno accompagnat* ed aiutat* nell’autoformazione; finché alcun* di noi hanno avvertito la necessità di concretizzare queste riunioni in qualcosa che avesse un maggior impatto politico.